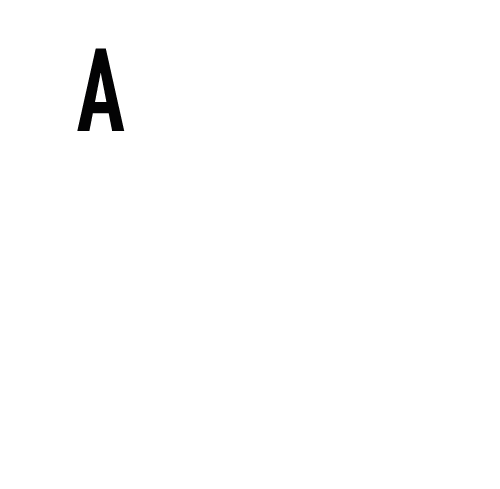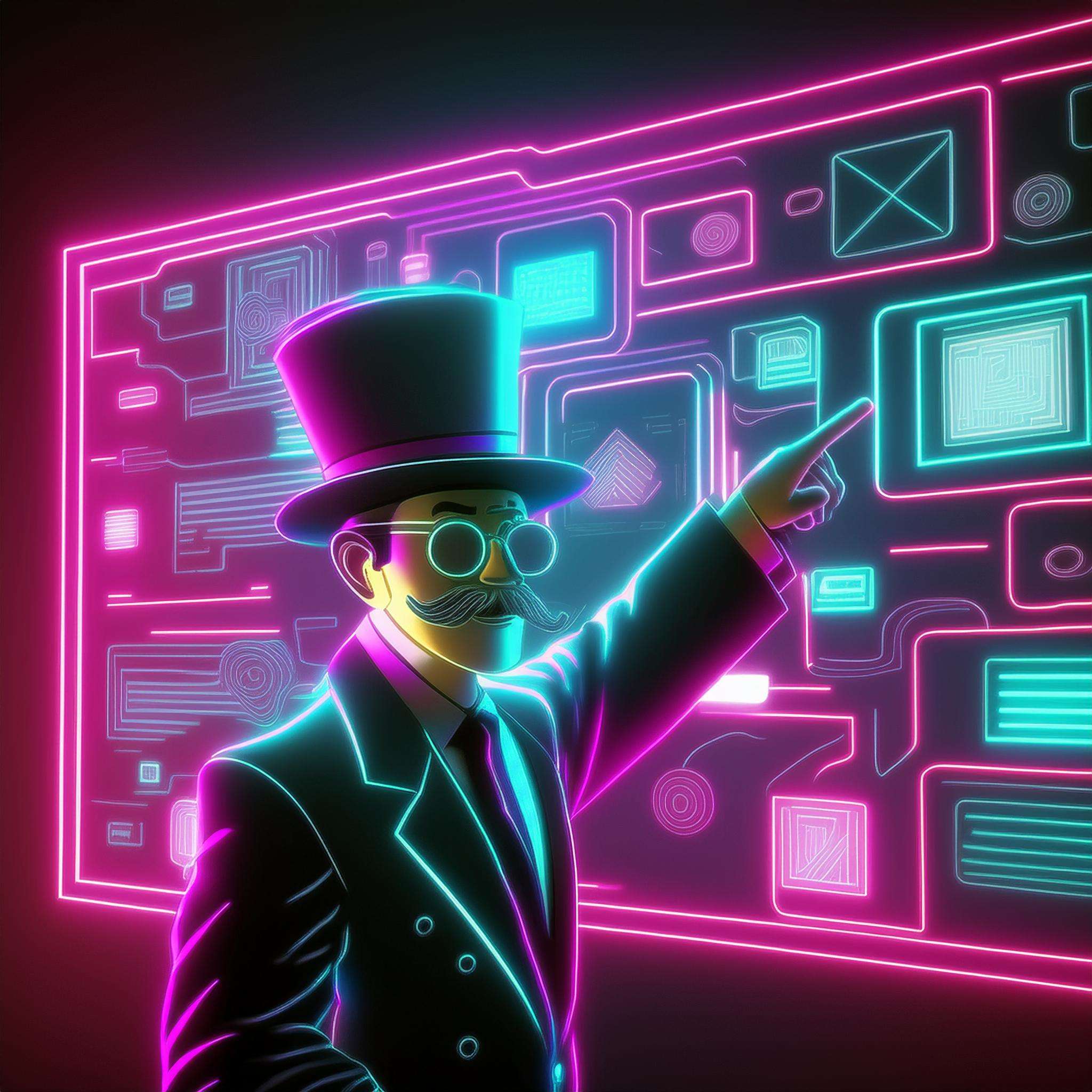Questo contributo di Nick Srnicek è stato pubblicato all’interno di “Work and Labour Relations in Global Platform Capitalism”, edito da Julieta Haidar e Maarten Keune – ILERA Publication series © International Labour and Employment Relations Association and International
Labour Organization 2021. Disponibile su elgaronline.com
Introduzione
Divenendo centrali nell’economia moderna, le riflessioni sul valore e sul contributo dei dati si sono moltiplicate1.
Con questo articolo cercheremo di districarci tra le varie interpretazioni del concetto di valore nell’economia digitale, evidenziando incoerenze e fraintendimenti, nonché di estrarre meccanismi e concetti utili.
In particolare, questo articolo criticherà l’approccio attualmente dominante in merito al valore dei dati, ovvero la tesi del lavoro gratuito [free labour], secondo la quale le nostre attività online producono un surplus di valore.
Sebbene questa tesi offra spiegazioni intuitive (e talvolta rassicuranti) in merito a come il valore viene prodotto, circolato e catturato, sosterrò che è comunque basata su assunzioni e deduzioni errate.
Al suo posto, proporrò una tesi che si concentra sui concetti di rendita [rent] e di appropriazione del valore, piuttosto che sulla sua creazione. Questa interpretazione si baserà su un approccio di analisi marxista dell’economia, in quanto utile per la comprensione delle dinamiche economiche che sottostanno al flusso superficiale dei prezzi, nonché per l’enfasi che pone sulle tendenze a medio e lungo termine all’interno di un modello di produzione storico.
L’obiettivo finale sarà, astrattamente, l’individuazione del luogo e dei modo in cui le piattaforme si posizionano all’interno dei circuiti teorici del valore del capitalismo contemporaneo2.
[…]Sebbene gran parte della discussione seguente sarà affrontata a un alto livello di astrazione, questi non sono argomenti meramente accademici. Toccano infatti alcuni temi fondamentali per la comprensione delle dinamiche sistemiche del capitale globale.
In particolare, la questione relativa alla veridicità della tesi del lavoro gratuito ha un’enorme influenza sulle modalità in qui procede oggi il capitalismo.
Se è vera, l’incorporazione di miliardi di utenti in un sistema digitale di accumulazione del capitale senza salario dovrebbe indicare che siamo prossimi – o presto lo saremo – a una nuova era di solida crescita economica3.
Se è falsa, dovremmo invece aspettarci un capitalismo ancora rallentato [sluggish] e incline a utilizzare ogni forma di misura emergenziale pur di scongiurare una sua crisi imminente.
L’aumento dei tassi di interesse negativi, i bilanci gonfiati delle banche centrali e la lentezza della ripresa successiva alla crisi del 2008 sono elementi che portano a considerare la tesi del lavoro gratuito con sospetto.
Questi approcci contrastanti hanno anche implicazioni diverse per quanto concerne il mondo del lavoro e le relazioni lavorative. La tesi del lavoro gratuito affermerebbe che il concetto di lavoro si sta gradualmente estendendo all’intera social factory e che le nostre attività vengono sempre di più incorporate direttamente nei circuiti del capitale.
Secondo questa tesi, alla fine importa poco se questa modalità di lavoro in espansione sia salariata o non salariata. L’approccio alternativo, invece, sosterrebbe che il lavoro salariato rimane il fulcro del processo di accumulazione e che gli sforzi per limitare il potere di questi lavoratori continuano a essere prioritari per il Capitale.
Il dibattito su dove e come viene creato il valore nell’economia digitale ha anche implicazioni politiche. Se la tesi del lavoro gratuito è corretta, allora esiste un motivo valido per sostenere che gli utenti di Facebook meritino un salario per la propria attività produttiva sulla piattaforma (sul modello di quanto fu originariamente oggetto di discussione nella campagna pro/contro i salari per il lavoro domestico)4 (Toupin 2018). Se la tesi è errata, allora le nostre risorse strategiche dovrebbero essere rivolte altrove.
Allo stesso modo esistono implicazioni che impattano qualsiasi tipologia di analisi strategica sul potere capitalistico. Un approccio basato sul lavoro gratuito presupporrebbe un basso livello di attrito tra le imprese di piattaforma e quelle non di piattaforma, mentre quello che elaboreremo in questo articolo individua un crescente antagonismo tra le due fazioni.
Per avere una migliore comprensione di quale approccio approssima meglio le condizioni del capitalismo contemporaneo, passeremo ora a un’analisi più approfondita dei diversi argomenti utilizzati.
1 – Una critica della tesi del lavoro libero
Originata sulla scia del boom delle dot.com con il lavoro pionieristico di Tiziana Terranova, la “tesi del lavoro gratuito” cosituisce l’approccio marxista dominante all’odierna economia guidata dai dati (Andrejevic 2014; Brown 2014; Cohen 2008; Coté e Pybus 2007; Fuchs 2017; Greene e Joseph 2015; Jarrett 2014; Terranova 2000).
Sebbene non manchino i critici, la tesi del lavoro gratuito si è consolidata come senso comune dominante negli scritti critici sull’economia digitale, ma anche come intuizione ampiamente diffusa sempre più presente nelle discussioni dei media mainstream (Posner e Weyl 2018; The Economist 2018).
Sebbene sia strettamente legata al filone autonomista marxista, le versioni più sofisticate di questa tesi si basano spesso sul lavoro di Dallas Smythe e sul suo approccio unico al ruolo della pubblicità nel capitalismo (Smythe 1977).
In questo articolo ci riferiremo al lavoro di Christian Fuchs come alla versione più sviluppata di questo approccio.
Per Fuchs, il tempo trascorso dagli utenti sulle piattaforme di social media produce valore sotto forma di dati-merce che vengono venduti agli inserzionisti (Fuchs 2014, pp. 89–90).
Ciò include sia le attività di creazione attiva di contenuti online, sia il più passivo “residuo di dati” generando semplicemente navigando le piattaforme. Questi dati-merce realizzano poi il proprio valore quando gli utenti interagiscono con gli annunci5 e l’inserzionista paga la piattaforma di conseguenza (Fuchs 2014, pp. 117–18). Queste attività online sono quindi oggetto di sfruttamento e produttrici di valore.
Il lavoro degli utenti sulle piattaforme può anche considerarsi ideologicamente oggetto di coercizione: infatti si può lasciare Facebook, ma solo abbandonando la piattaforma stessa, un mezzo fondamentale di socialità (Fuchs 2014, pp. 90–1).
Questo aspetto è importante perché un elemento chiave del lavoro salariato è proprio il suo essere oggetto di coercizione: se il proletariato avesse accesso ai propri mezzi di sussistenza, non avrebbe bisogno di competere nel mercato del lavoro e il capitalismo perderebbe il suo generatore di valore6.
[…]. Infine, Fuchs sostiene anche che, così come il lavoro salariato, anche questa tipologia di lavoro online è alienata [dai mezzi di produzione] in quanto i lavoratori non possiedono i dati e i contenuti che producono.
Ci sono diversi argomenti che possono essere utilizzati contro questa posizione. […] Iniziamo accettando pienamente gli assunti alla base della tesi del lavoro libero, ovvero che le nostre attività online generano valore. In questo caso possiamo però sollevare immediatamente dubbi su quanto sia significativa questa nuova fonte di creazione di valore per l’economia digitale7.
Considerando le principali piattaforme occidentali8, solo Facebook e Google dipendono dalla pubblicità9. Amazon sta aumentando la sua quota di entrate provenienti dall’advertising, ma rimane molto più dipendente dal cloud computing e dalla sua piattaforma di e-commerce. Apple e Microsoft hanno revenues provenienti da advertising contenute, con business dominati da altri elementi.

Anche considerando i due oligopoli pubblicitari, Google si sta orientando verso nuove fonti di reddito sotto forma di cloud computing, giochi e hardware di consumo generale. Ciò denota una strategia sempre più orientata ai servizi per le imprese. Amazon Web Services ne è forse l’esempio più chiaro, dato che il reddito operativo della società proviene in gran parte da servizi rivolti alle aziende piuttosto che dall’e-commerce rivolto ai consumatori.
Quindi, anche se l’argomento del lavoro gratuito fosse del tutto corretto, sembrerebbe rappresentare solo una piccola (e in diminuzione) porzione dell’economia digitale.
Andando più alla radice, possiamo chiederci se queste attività siano effettivamente generative di plusvalore. Il quadro marxista offre un insieme molto rigoroso di condizioni che devono essere soddisfatte affinché il plusvalore venga creato da un processo di produzione.
In particolare, quello che produce valore è il lavoro salariato che opera nel contesto di un processo di produzione, con mercati per gli input (lavoro, in particolare) e mercati per l’output, nonché con l’obiettivo generale di incrementare il valore. (Importante, questo non significa che il lavoro che produce valore sia solo industriale o fisico – ogni settore economico, così come il lavoro immateriale, può essere considerato produttore di valore nelle giuste condizioni.)
Le nostre attività online soddisfano questi criteri? Innanzitutto, tipicamente queste aziende non vendono i dati personali dei propri utenti. Mentre i broker di dati mirano a monetizzarli in qualche modo, questo modello di business non si applica alle piattaforme pubblicitarie (Christl e Spiekermann 2016; Federal Trade Commission 2014).
Invece, ciò che aziende come Facebook e Google fanno è utilizzare questi dati per creare e offrire spazi pubblicitari mirati per i quali le aziende possono fare offerte, ovvero non vendono dati a un’altra entità.
Tuttavia, anche se i dati fossero mercificati e venduti, non costituirebbero prodotti scambiati in un mercato competitivo con l’obiettivo di aumentare il valore.
In parole semplici, il fatto che qualcosa sia venduto in un mercato non implica che questo qualcosa sia una commodity in senso capitalista. Affinché ciò avvenga il processo di produzione della merce deve essere – almeno – orientato al mercato, alla creazione di plusvalore e al reinvestimento di quel valore in un nuovo ciclo di produzione. Per alcune commodities, queste condizioni semplicemente non sussistono: ad esempio per le piccole merci prodotte informalmente nelle economie in via di sviluppo, per la maggior parte dei prodotti artistici e delle attività online (Sanyal 2013; Beech 2016).
Forse, più concretamente, non esiste una nozione di tempo di lavoro socialmente necessario – e quindi nessuna nozione di lavoro astratto (produttivo di valore) – all’interno del “lavoro” non retribuito delle attività online.
Non esiste una mediazione di mercato di questo “lavoro”, che renderebbe il lavoro inefficiente non competitivo e che guiderebbe la ricerca sistemica di una maggiore produttività. Non c’è, in altre parole, uno standard implicito con il quale qualsiasi processo di produzione possa essere misurato come efficiente o inefficiente.
Ad esempio, se un dato-merce viene prodotto dalle nostre attività online, quale quantità di tempo di lavoro socialmente necessario (SNLT) incorpora? Fondamentalmente, è impossibile determinarlo. il concetto stesso di SNLT non può prescindere dalla competizione tra diversi produttori, mediata dal mercato e validata dallo scambio, per esistere. In assenza di queste condizioni, tutto ciò che abbiamo è tempo di lavoro concreto e valori d’uso. È quindi significativo che quando Fuchs calcola il valore creato dagli utenti non retribuiti di Facebook, si basi sul tempo di lavoro concreto (Fuchs 2014, p. 105).
Non esiste una nozione di tempo di lavoro astratto che possa essere utilizzata per effettuare gli stessi calcoli. Infatti, si potrebbe sostenere che la natura stessa dei dati personali implica che essi non possano essere soggetti a un processo di produzione capitalista senza distruggere le caratteristiche stesse che li rendono utili, in primo luogo il loro essere espressione (relativamente) spontanea e non gestita del comportamento di qualcuno.
Se i processi che generano dati personali autentici fossero realmente sussunti, questi dati diventerebbero un’espressione (prevedibile e inutile) di un processo di produzione razionalizzato, piuttosto che un’espressione del sé.
Tutto questo non vuol dire che le attività online non possano essere produttive di valore. Il social media manager di un’azienda può trascorrere parte del proprio tempo producendo contenuti da condividere online, e questo sarebbe lavoro produttivo di valore. La differenza sta nelle relazioni sociali in cui viene inserita la stessa attività: salariata e guidata da imperativi capitalistici, o no?
2 – L’ascesa dei Rentiers
Una parte importante del motivo per cui la tesi del lavoro gratuito risulta al momento dominante è che sembra utilizzare con una certa parsimonia un’intuizione chiave dell’economia delle piattaforme, ovvero che i nostri dati personali sono incredibilmente preziosi per i giganti della tecnologia.
Eppure, come abbiamo sostenuto fin qui, la tesi del lavoro gratuito si basa su un’applicazione illegittima del concetto di lavoro produttivo al di fuori del suo ambito. Quindi, come possiamo spiegare contemporaneamente l’utilità dell’attività di estrazione dei dati e l’enorme disponibilità di risorse e ricchezze delle piattaforme più grandi?
Per cominciare, dobbiamo ricordare che nell’approccio marxista la distribuzione del valore non corrisponde necessariamente e direttamente alla produzione del valore. Il modo più semplice per comprendere questa asimmetria è immaginare i processi di produzione del capitalismo come un ampio bacino di plusvalore, distribuito e acquisito da una varietà di attori, capitalisti e non.
Ciò non implica una relazione diretta o necessaria tra il plusvalore creato da un capitalista e il plusvalore di cui si appropria lo stesso soggetto. Per quanto riguarda i giganti delle piattaforme, ciò significa che la loro capacità di catturare valore non è necessariamente correlata alla loro capacità immanente di produrre valore.
La prima modalità in cui questa divergenza tra produzione e appropriazione si genera è attraverso il livellamento del tasso di profitto tra le industrie10.
Data la tendenza del Capitale a cercare il tasso di profitto più alto, i produttori si muovono sempre verso i settori con i tassi di profitto più alti. Questo porta a una maggiore offerta (poiché le imprese esistenti investono di più per sfruttare i profitti elevati) e a una maggiore concorrenza (per via delle nuove aziende entranti nel mercato in cerca di profitti elevati). Per questi motivi le dinamiche che ne conseguono scaturiscono nella creazione di un tasso di profitto per quel dato settore globalmente più basso.
Il processo opposto accade nelle industrie con un basso tasso di profitto, fino a un punto (tendenziale) in cui i tassi si eguagliano tra le diverse industrie. […] Quelle con bassa composizione organica creeranno la maggior parte del plusvalore, ma come risultato del processo di livellamento tenderanno a ricevere meno valore di quanto ne abbiano creato. Al contrario, le industrie con alta composizione organica creeranno meno plusvalore ma se ne approprieranno in misura maggiore.
La seconda modalità che causa una divergenza tra la posizione in cui si produce valore e quella in cui si verifica la sua appropriazione è legata all’uso del potere economico e politico, finalizzato alla cattura del plusvalore creato altrove. Ad esempio: un capitalista finanziato con un grande debito può produrre una quantità significativa di plusvalore, ma i pagamenti di interessi e tasse faranno si che una parte di quel plusvalore sia distribuita al capitale finanziario e al governo.
Gli ultimi due attori non hanno necessariamente creato alcun valore, ma hanno fornito servizi necessari per la riproduzione e la realizzazione del capitale produttivo iniziale. I loro ruoli e posizioni all’interno del processo complessivo di accumulazione gli consentono di appropriarsi di plusvalore nonostante non ne producano alcuno. Di conseguenza, il capitalista finisce con meno plusvalore di quanto ne abbia prodotto.
Questo è un processo generale, presente in tutto il sistema capitalistico:
Ci sono molti altri modi di appropriazione del plusvalore, come la monopolizzazione di settori del mercato, il marketing e la pubblicità, l’istituzione di diritti di proprietà intellettuale attraverso brevetti, diritti d’autore e marchi, il possesso di risorse energetiche o altre risorse naturali scarse, la superiorità nell’organizzare transazioni finanziarie o nello strutturare diritti di proprietà finanziaria, il controllo dei trattamenti medici, e così via. (Foley 2013, p. 260)
Attraverso una varietà di mezzi, quindi, gli attori economici (che siano capitalisti o meno) tenderanno a usare il potere di cui dispongono per catturare la più alta quota di valore possibile dal bacino aggregato di plusvalore.
Questo secondo processo è particolarmente utile a spiegare il dominio contemporaneo dei giganti delle piattaforme11. Per il resto di questo articolo, infatti, sosterremo che “rendita” è il concetto più appropriato per comprendere la collocazione delle piattaforme nel processo di accumulazione del capitale12.
Questa argomentazione si baserà, pur divergendone in alcuni punti, su diversi contributi recenti sull’argomento (Christophers 2019; Fine 2019; Mazzucato 2019; Rigi e Prey 2015; Sadowski 2019, 2020; Zeller 2007).
Cosa intendiamo per rendita?
Non l’idea neoclassica di ricerca di rendita, che si riferisce a quel tipo di interferenza del governo nei mercati che consente a un’azienda di estrarre profitti più alti di quanto sarebbe altrimenti possibile (Birch 2019, p. 10). Questo concetto infatti rimane legato a un’immagine neoclassica dei mercati e degli Stati che postula la competizione perfetta come stato naturale delle cose.
Al contrario attingeremo alla nozione marxiana di rendita che, pur essendo focalizzata sulla proprietà terriera, può essere generalizzata per una comprensione più ampia delle dinamiche odierne.
Sebbene Marx distingua tra le tipologie differenziale, assoluta e di monopolio, la rendita costituisce in tutti e tre i casi un reddito che deriva dalla proprietà o dal controllo di un bene scarso (Birch 2019, p. 2; Christophers 2019, p. 2; Foley 2013)13.
Questa nozione è utile nella nostra analisi per diversi motivi. In primo luogo, come argomentato sopra, aiuta a collocare le piattaforme in relazione all’economia produttiva. In secondo luogo, aiuta a capire come la quota preponderante del valore dei giganti digitali sia legata alla proprietà e/o al controllo di beni scarsi. Ciò riguarda in modo più evidente i dati personali, ma anche le infrastrutture e le proprietà intellettuali.
Infine il concetto generale di rendita ci conduce a un punto fondamentale: mentre Marx scriveva della rendita come qualcosa derivante da un bene naturale (cioè la terra), l’idea di rendita come proprietà e/o controllo di un bene scarso può essere applicata sia ai beni naturali che a quelli non naturali. Questo ci consente di estendere l’idea – e il meccanismo di cattura del valore – a una gamma molto più ampia di fenomeni economici rispetto al caso tradizionale.
Nel lavoro di Christophers, per esempio, sono delineati otto diversi tipi di beni, ciascuno con una storia e una dinamica particolari (Christophers 2019). La distinzioni tra beni naturali e non naturali, a sua volta, ha dato origine nel tempo a diverse discussioni legate alla loro produzione, manutenzione e giustificazione.
La proprietà terriera, ad esempio, è considerata più spesso “improduttiva” in confronto alla proprietà di beni non naturali, la cui capacità produttiva viene spesso chiamata in causa nei contenziosi riguardanti la proprietà intellettuale.
Con queste caratteristiche fondamentali della rendita in mente, la parte rimanente di questa trattazione sosterrà l’esistenza di tre meccanismi prominenti di rendita nell’economia digitale contemporanea: le rendite da proprietà intellettuale, le rendite pubblicitarie e le rendite infrastrutturali.
Ognuna di queste è in gioco, in vari gradi, in tutte le principali piattaforme[…]. Le rendite pubblicitarie sono ovviamente più strettamente associate a quelle che trovano nell’advertising la loro principale fonte di reddito. Le rendite infrastrutturali sono, invece, maggiormente appannaggio delle piattaforme cloud e delle lean platforms14.
L’attività delle piattaforme, in generale, ha a che fare principalmente con la cattura del valore da altri comparti dell’economia. I dati, in questa lettura, non sono tanto la fonte di tutto il valore digitale, ma piuttosto un mezzo per arrivare alla massimizzazione delle rendite.
Sono un input prezioso (cioè materia prima) che consente, ad esempio, la creazione di spazi pubblicitari personalizzati, la produzione di nuovi beni e servizi proprietari (come un motore di ricerca) e l’ottimizzazione di beni e servizi esistenti (come il cloud computing).
Anche se esistono casi in cui i dati sono considerabili come una merce scambiata sul mercato, più spesso essi agiscono come un input funzionale a differenziare le aziende dai loro concorrenti. Piuttosto che vedere i dati come il risultato di un’attività di sfruttamento, quindi, è più utile vederli come il risultato di una appropriazione.
3 – Rendite di proprietà intellettuale

La prima grande fonte di rendite per le piattaforme digitali – la proprietà intellettuale (IP) – è stata trattata in modo piuttosto esteso nella letteratura esistente (Foley 2013; Frase 2016; Perelman 2003; Stalder 2018).
In questa fattispecie, le aziende creano – o oggi, più spesso, acquistano – conoscenze, informazioni, tecnologie e altri prodotti immateriali di valore. A differenza degli asset fisici tradizionali, non esiste una ragione a priori per cui questi asset immateriali non possano essere replicati e diffusi a chiunque possa trovarli utili. Tranne nei casi in cui -ed è cruciale- lo Stato applica e fa rispettare diritti di proprietà intellettuale che permettono alle aziende di impedire l’utilizzo di questi asset immateriali da parte di altri.
In altre parole, lo Stato estende la forma della proprietà ai prodotti intellettuali, concedendo così un monopolio sulla stessa15. Con la proprietà monopolistica di un asset scarso, le aziende sono quindi in grado di ottenere una rendita da altri attori economici che vogliono accedere a quella risorsa16.
Oggi queste rendite giocano un ruolo importante in diverse industrie, come quella farmaceutiche, biotecnologiche, dei prodotti di consumo e dell’intrattenimento (Christophers 2019) [..] [nonché] nelle industrie high-tech.
Il potere delle principali piattaforme digitali si basa, in misura significativa, sulla proprietà intellettuale. Molte di esse generano entrate significative anche attraverso la concessione strategica di licenze IP.
Microsoft è forse leader in questo senso nel panorama digitale, vantando oltre 61.000 brevetti (con ulteriori 26.000 in attesa) e riportando 17,3 miliardi di dollari di asset intangibili (prima dell’ammortamento) nei suoi bilanci del 2019 (Microsoft 2019). La loro importanza è tale che (senza la proprietà intellettuale relativa a Microsoft Windows, per esempio) sarebbe difficile collocare questa azienda nella posizione di leadership che detiene attualmente.
Questo ci permette di sottolineare un altro aspetto importante della proprietà intellettuale: per creare potere di mercato, essa può essere utilizzata in vari modi, generando rendite in forma diretta e indiretta (Christophers 2019; Zeller 2007).
La rendita più ovvia è il reddito che deriva dall’addebitare a terzi l’accesso alla propria proprietà intellettuale. Microsoft, ad esempio, addebita agli utenti una tassa per scaricare e utilizzare il sistema operativo Windows, e il recente spostamento di Microsoft verso il software cloud implica che questo accesso posa essere costantemente minacciato di ritiro.
Più in generale, tasse di licenza e pagamenti di royalty sono tutti esempi di questa tipologia.
Una seconda forma di rendita IP emerge quando un’azienda utilizza la proprietà intellettuale per creare un prodotto o un servizio che, a causa dell’esclusione IP, altri non possono copiare.
L’azienda può quindi vendere quel prodotto e raccogliere i frutti dei diritti di monopolio sulla proprietà intellettuale che ne costituisce il cuore stesso. Ne sono esempi molte piattaforme di Google, con il loro know-how proprietario espresso in servizi funzionali ad attrarre utenti, estrarre i loro dati e ingaggiare gli inserzionisti.
Infine, la rendita IP può verificarsi anche quando un’azienda vende direttamente i suoi diritti di proprietà intellettuale a un’altra azienda, trasformando efficacemente la proprietà intellettuale in un asset finanziario che può essere utilizzato per ottenere immediatamente un flusso di reddito.
Ad esempio, nel 2011 Google ha speso oltre 12 miliardi di dollari per acquisire un’azienda di smartphone, Motorola Mobility (Taylor e Waters 2011). Sebbene Motorola fosse considerata un’azienda in ritardo all’epoca, aveva accesso a più di 17.000 brevetti cruciali per la lotta di Google con Apple. Per questo motivo i suoi proprietari sono stati in grado di trasformarli direttamente in prodotti da vendere.
Come per le altre rendite, la loro esistenza è spesso basata su un nucleo fondamentale di produzione di plusvalore. In questo caso la creazione iniziale di proprietà intellettuale è (tipicamente) un’attività generatrice di valore. I salari, il capitale fisso e il processo di produzione impiegato nella produzione di beni immateriali non sono diversi in termini di valore dai processi utilizzati per i beni materiali. Entrambi quindi sono in grado di generare plusvalore nel processo di produzione.
La differenza emerge dopo la produzione del bene, quando la possibilità di riproduzione diffusa ed economica della proprietà intellettuale (IP) viene invece bloccata dai diritti di monopolio , generando un flusso di rendita. Inoltre, poiché la proprietà intellettuale è non rivale, la potenziale rendita non è vincolata negli stessi modi in cui potrebbe esserlo la terra, riducendo l’importanza del processo di produzione iniziale17.
Rendite pubblicitarie
La rendita più evidente, che ha un impatto significativo e diretto sugli utenti di internet, è la pubblicità. Qui il possesso monopolistico dei dati personali – e gli effetti di rete che attraggono dati degli utenti – si combina con la creazione e il controllo di spazi online per l’advertising mirato.
Più dati si possiedono, più personalizzata può diventare un’inserzione. Ciò determina che un ristretto numero di aziende con enormi quantità di dati personali sia in grado di dominare efficacemente il mercato.
Gli inserzionisti, desiderosi di diffondere la conoscenza dei loro prodotti, si affidano a questi beni scarsi pagando una rendita ai loro proprietari per pubblicare le loro inserzioni negli spazi più preziosi. In termini marxisti tradizionali, questo è un flusso di plusvalore che si sposta dai comparti produttivi dell’economia verso un settore non produttivo, orientato alla realizzazione e alla convalida del plusvalore, ma che non ha un ruolo diretto nella sua produzione. A tutti gli effetti quindi, il ristretto numero di aziende che controlla i dati […] costruisce un ambiente online che poi affitta ad altri per una tariffa.
Due delle più grandi piattaforme occidentali, Facebook e Google, sono quasi interamente dipendenti dall’estrazione delle rendite pubblicitarie. Nei loro rapporti finanziari più recenti queste due aziende hanno ricavato dall’advertising rispettivamente il 98,5% e l’85,8% delle proprie entrate18. Un’altra grande piattaforma, Amazon, sta vedendo una rapida crescita in quest’area (Weise 2019).
La fonte del potere particolare di queste aziende nel mercato della pubblicità digitale, tuttavia, deriva dal loro controllo su enormi quantità di dati personali. Questi sono utilizzati per ridurre i costi (necessari per ottenere informazioni sugli individui) e per creare sistemi di targeting che offrono spazi pubblicitari di primo piano per coloro che vogliono commercializzare i propri prodotti.
Questo non significa che la pubblicità non svolga un ruolo teorico nel valore nel capitalismo. Ad esempio, la produzione di piattaforme pubblicitarie può, di per sé, generare plusvalore poiché impiega capitale costante e variabile nella produzione di beni quali ricerche di mercato, piattaforme tecnologiche e altri output. Ma in generale il ruolo della pubblicità è fortemente circoscritto e quasi interamente relativo alla distribuzione del valore piuttosto che alla sia produzione. La pubblicità può spostare la domanda da un’azienda a un’altra, o da un settore a un altro, ma in entrambi i casi configura unicamente una ridistribuzione della domanda.In effetti può anche creare nuova domanda, ma al massimo riducendo il tempo di turnover del processo produttivo19 (Lebowitz 1986, p. 168).
Con la pubblicità mirata, la promessa è che i dati raccolti possano consentire agli inserzionisti di trovare i consumatori più rapidamente – e a minor costo – riducendo così il loro tempo di turnover e permettendo al capitale impiegato nel processo di essere indirizzato verso la produzione.
Come dice Bruce Robinson, “Funzionalmente, può essere visto come un ruolo analogo a quello svolto dalla ricerca di mercato tradizionale, mirato a fornire la base per una relazione più precisa tra il venditore e il mercato” (Robinson 2015, pp. 46–7). In altre parole, la pubblicità può consentire ai singoli capitalisti di creare surplus più rapidamente, ma la pubblicità, di per sé, non crea surplus (Caraway 2016, p. 77).
Rendite di infrastruttura

Mentre le rendite da proprietà intellettuale e da pubblicità sono state trattate ampiamente nella letteratura esistente, la terza forma principale di rendita è stata discussa molto meno.
Le rendite da infrastrutture emergono dalle tariffe pagate per l’accesso all’uso di una piattaforma. Come sottolinea Christophers, tali rendite non sono né naturali (come la terra) né create dallo Stato (come la proprietà intellettuale), ma emergono invece dagli effetti di rete che spingono le piattaforme verso posizioni monopolistiche (Christophers 2019, p. 11). La loro scarsità è prodotto di queste dinamiche e, man mano che l’economia si digitalizza, i proprietari di queste piattaforme acquisiscono maggiore controllo sulle tariffe che possono essere addebitate per accedervi.
Il cloud computing è forse l’esempio più chiaro, con le aziende che affittano l’accesso a hardware e software che, in un’epoca precedente, avrebbero posseduto. Tuttavia, le rendite da infrastrutture emergono anche, in misura meno evidente, dal modello di business “as-a-service” in cui altri mantengono la proprietà di un determinato bene (automobili, case, biciclette, ecc.) e poi addebitano agli utenti una tariffa per accedervi per un certo periodo di tempo.
Come ha detto Jathan Sadowski, attraverso questo modello “le piattaforme sono state in grado di espandere le relazioni di rendita a qualsiasi attività quotidiana” (Sadowski 2019).
Le rendite infrastrutturali esistono anche sotto forma di piattaforme di intermediazione a cui si affidano soggetti terzi. Ne sono esempi Uber e Airbnb, appropriandosi di una parte della transazione economica resa possibile dalla loro piattaforma (Christophers 2019, p. 11). Gli attori economici che utilizzano queste piattaforme stanno, in effetti, pagando una tassa ai proprietari della piattaforma per poter utilizzare il loro bene scarso.
Mentre una parte delle rendite infrastrutturali emerge dal controllo di proprietà intellettuale chiave, il capitale fisso è un aspetto essenziale per la loro esistenza. AWS ne è un ottimo esempio, con enormi quantità di denaro spese per la costruzione di un’infrastruttura informatica di dimensioni planetarie – una scala che preclude a tutti, tranne pochi concorrenti (attualmente, Microsoft, Google e Alibaba), di avere una possibilità in questo mercato.
Questa infrastruttura produce un’enorme quantità di ricavi per Amazon. Nel 2017, ad esempio, oltre il 100 per cento del reddito operativo dell’azienda proveniva da AWS20. In effetti, nel resto dei suoi comparti Amazon stava perdendo denaro, mentre l’unità di cloud computing generava più di 4 miliardi di dollari di reddito operativo. Tale è l’influenza delle rendite infrastrutturali nella nostra era.
Come per le altre forme di rendita, però, non possiamo parlare di attività del tutto improduttive, dato che il cloud computing ha diversi tipi di impatto sulla produzione del valore. In primo luogo, il cloud computing è desiderabile per le imprese perché consente una rapida espansione delle risorse, spesso con livelli di competenza tecnica che vanno ben oltre ciò che le imprese stesse possono fornire, aumentando efficacemente la produttività e l’estrazione di plusvalore relativo.
Allo stesso modo, le piattaforme puramente intermediarie si sono espanse rapidamente in parte perché riducono i costi di transazione e quindi (almeno potenzialmente) aumentano il tasso di profitto per le aziende che vi si affidano. Il loro impatto sulla creazione di valore si estende anche alla capacità di ridurre i tempi di turnover, permettendo che meno capitale venga immobilizzato nel processo di circolazione, consentendo così di dedicarne di più ad attività produttive (Dantas 2019, p. 142).
Conclusioni
Considerate queste tre forme di rendita, la principale conclusione da trarre è che gran parte del capitalismo delle piattaforme si basa sull’appropriazione di un valore prodotto altrove nell’economia globale.
Come abbiamo sottolineato, ciò non significa che non abbiano alcun impatto sull’accumulazione di valore, poiché, ad esempio, le piattaforme possono ridurre i costi di transazione per altre imprese e quindi influire sul loro tasso di creazione di plusvalore.
Né significa che non abbiano creato quello che gli economisti mainstream chiamano ‘surplus del consumatore’, che non viene misurato con parametri basati su forme monetarie (Brynjolfsson et al. 2019). Tuttavia, ciò che è in definitiva determinante per il capitalismo in quanto sistema è l’accumulazione di capitale espressa in forma monetaria. E in questi termini, le piattaforme sono più ostacoli che acceleratori.
Ciò comporta una serie di conseguenze dirette. Se le piattaforme sono prevalentemente rentiers, allora il capitalismo non solo non ha creato una nuova fonte di valore, ma si trova di fronte a un nuovo ostacolo alla sua accumulazione – una conclusione diametralmente opposta alla tesi del lavoro gratuito.
La crescita di questo settore rentier è doppiamente dannosa per il Capitale. Implica, innanzitutto, una riduzione del tasso medio di profitto, dato che questi settori non produttivi devono ricevere lo stesso tasso di profitto degli altri, non generando però nuovo plusvalore autonomamente. Agiscono unicamente come fattori di diluizione del plusvalore totale tra più capitalisti.
In secondo luogo, poiché questi rentiers tecnologici sono monopolisti, impediscono anche l’uguaglianza del tasso di profitto ostacolando il flusso di capitale verso i concorrenti diretti.
Di conseguenza, non solo si appropriano del plusvalore delle imprese produttive, ma lo fanno in misura maggiore rispetto alla media delle altre imprese21. Tutto ciò comporta anche l’emergere di un antagonismo tra frazioni di capitale: tra i proprietari delle piattaforme e le aziende non piattaforme che dipendono sempre più da loro e pagano una rendite.
Come Marx e altri hanno notato, i rentiers hanno interessi di classe diversi rispetto ai capitalisti produttivi o ai lavoratori. (Neocosmos 1986). Nonostante le varie narrazioni sul feudalesimo digitale o sui metodi di produzione emergenti, questa lotta avviene all’interno di imperativi strutturali definiti dal capitalismo: una lotta per la distribuzione del plusvalore piuttosto che per il suo superamento (Wark 2019).
La funzione ostacolante della rendita è moderata da un’altra caratteristica comune a molte di queste aziende. Da un lato, esse appaiono come monopoli che dominano i loro settori particolari (motori di ricerca, e-commerce, social media, ecc.), eppure non denotano molte delle caratteristiche ortodosse dei monopoli: per esempio, la riduzione della produzione o dell’innovazione.
Anzi (e questo ci conduce a un importante mistero contemporaneo) queste aziende monopolistiche sembrano invece i principali innovatori e investitori nell’economia globale. Nell’economia statunitense, per esempio, i giganti della tecnologia sono tra i maggiori investitori in conto capitale e ricerca e sviluppo (Meeker 2018).
Questa non è l’attività usuale dei rentiers classici, tipicamente presentati come ostacoli all’accumulazione di capitale. Il dato è ancora più sorprendente se si considera che, in generale, il periodo post 2008 è stato uno dei più fiacchi negli Stati Uniti per crescita degli investimenti22. Eppure i giganti della tecnologia hanno rappresentato una notevole eccezione a questa tendenza. Quindi abbiamo capitalisti produttivi che non investono e rentiers non produttivi che invece investono. Come interpretare tutto ciò?
Sebbene non sia del tutto chiaro, si presentano due ipotesi.
La prima riguarda la disaggregazione delle funzioni di accumulazione del capitale. Per esempio, Marx notò che, a volte, diversi tipi di capitale (di produzione, commerciale, finanziario) potevano convergere in un’unica impresa, mentre in altri momenti, imprese specializzate potevano concentrarsi su funzioni particolari. Pur non essendo un tipo distinto di capitale, forse oggi stiamo assistendo a un caso in cui la funzione di investimento del processo di accumulazione viene spostata su particolari imprese?
Una seconda ipotesi si basa sui dibattiti di geografia economica degli anni ’70 e ’80, inerenti il modello standard dei rentiers come ostacoli all’accumulazione e una nuova interpretazione che sosteneva avessero importanti funzioni distributive per il capitale (Haila 1988).
Come sostiene David Harvey e altri, in un certo momento la terra stava diventando un bene finanziario tramite il quale i proprietari avevano interesse ad attrarre gli usi più produttivi del capitale nel tentativo di generare rendimenti più elevati, nell’immediato e per il futuro (Haila 1988, pp. 83–4; Harvey 2006).
Nella misura in cui le rendite pubblicitarie e di proprietà intellettuale si basano entrambe sul meccanismo dei prezzi per distribuire un’offerta finita a una domanda molto più ampia, potremmo vederle come operanti in modo simile una funzione di distribuzione utile per il capitale (le rendite infrastrutturali, al contrario, sembrano al momento molto meno soggette a questa dinamica, poiché l’offerta supera la domanda). A sua volta, l’investimento rappresenta uno sforzo razionale da parte delle piattaforme, funzionale ad espandere i loro imperi basati sulle rendite.
In entrambe le ipotesi si tratta di aziende stanno espandendo i propri imperi infrastrutturali in tutta l’economia. Se i loro investimenti sono in gran parte destinati all’ulteriore espansione di questo apparato (una questione aperta), allora stiamo davvero assistendo a un significativo cambiamento nel potere intra-capitalista.
Quando ci rivolgiamo al mondo del lavoro, possiamo notare come questi cambiamenti di carattere macroeconomico abbiano anche altri impatti significativi. In generale, la cattura del valore globale da parte di una manciata di piattaforme dovrebbe portare ad un’esacerbazione delle disuguaglianze tra i lavoratori, con quelli impiegati nelle aziende non-piattaforma sottoposti a crescenti pressioni e i lavoratori delle principali piattaforme a godere – anche se non è sempre così – di migliori condizioni di lavoro.
Questo è particolarmente vero per i lavoratori ad alta specializzazione nelle piattaforme pubblicitarie e cloud, che continuano a raccogliere profitti significativi dalle loro posizioni. D’altro canto, le piattaforme lean – nonostante la loro capacità di monopolizzare le rendite infrastrutturali – rimangono afflitte da margini ridotti e lavoratori che affrontano il peso di queste difficili condizioni economiche.
In ogni caso, qualsiasi congiuntura del capitalismo è una miscela unica di continuo e discontinuo, e mentre usiamo le continuità per far luce sui giganti delle piattaforme digitali, è chiaro che rimangono significative novità che devono ancora essere completamente comprese.
Riferimenti
– Andrejevic, M. (2014), Surveillance in the Big Data Era, in K. D. Pimple (ed.),
Emerging Pervasive Information and Communication Technologies (PICT),
Springer Netherlands, 55–69.
– Beech, D. (2016), Art and Value: Art’s Economic Exceptionalism in Classical,
Neoclassical and Marxist Economics, Chicago: Haymarket Books.
– Birch, K. (2019), Technoscience Rent: Toward a Theory of Rentiership for
Technoscientific Capitalism, Science, Technology, & Human Values. https://doi
.org/10.1177/0162243919829567
– Brown, B. (2014), Will Work For Free: The Biopolitics of Unwaged Digital Labour,
TripleC: Communication, Capitalism & Critique, 12 (2), 694–712.
– Brynjolfsson, E., A. Collis, W. E. Diewert, F. Eggers and K. J. Fox (2019), GDP-B:
Accounting for the Value of New and Free Goods in the Digital Economy, Working
Paper 25695, National Bureau of Economic Research.
– Caffentzis, G. (2013), In Letters of Blood and Fire: Work, Machines, and the Crisis of
Capitalism, Oakland, CA: PM Press.
– Caraway, B. (2016), Crisis of Command: Theorizing Value in New Media,
Communication Theory, 26 (1), 64–81.
– Christl, W. and S. Spiekermann (2016), Networks of Control: A Report on Corporate
Surveillance, Digital Tracking, Big Data & Privacy, Wien: Facultas.
– Christophers, B. (2019), The Rentierization of the United Kingdom Economy,
Environment and Planning A: Economy and Space. https://doi.org/10.1177/
0308518X19873007
– Cohen, N. (2008), The Valorization of Surveillance: Towards a Political Economy of
Facebook, Democratic Communiqué, 22 (1). Accessed 5 October 2019 at https://
journals.flvc.org/demcom/article/view/76495
– Coté, M. and J. Pybus (2007), Learning to Immaterial Labour 2.0, Ephemera, 7 (1),
88–106.
– Dantas, M. (2019), The Financial Logic of Internet Platforms: The Turnover Time of
Money at the Limit of Zero, TripleC: Communication, Capitalism & Critique. Open
Access Journal for a Global Sustainable Information Society, 17 (1), 132–58.
– Dedrick, J., K. L. Kraemer and G. Linden (2010), Who Profits from Innovation in
Global Value Chains?: A Study of the iPod and Notebook PCs, Industrial and
Corporate Change, 19 (1), 81–116.
– Federal Trade Commission (2014), Data Brokers: A Call for Transparency and
Accountability.
– Fine, B. (2019), Marx’s Rent Theory Revisited? Landed Property, Nature and Value,
Economy and Society, 48 (3), 1–12.
– Foley, D. (2013),Rethinking Financial Capitalism and the “Information” Economy,
Review of Radical Political Economics, 45 (3), 257–68.
– Frase, P. (2016), Four Futures: Life after Capitalism, London: Verso.
– Fuchs, C. (2014), Digital Labour and Karl Marx, New York: Routledge.
– Fuchs, C. (2017), The Information Economy and the Labor Theory of Value,
International Journal of Political Economy, 46 (1), 65–89.
– Greene, D. M. and D. Joseph (2015), The Digital Spatial Fix, TripleC: Communication,
Capitalism & Critique, 13 (2), 223–47.
– Haila, A. (1988), Land as a Financial Asset: The Theory of Urban Rent as a Mirror of
Economic Transformation, Antipode, 20 (2), 79–101.
– Harvey, D. (2006), The Limits to Capital, London: Verso Books.
– Jarrett, K. (2014), The Relevance of “Women’s Work”: Social Reproduction and
Immaterial Labor in Digital Media, Television & New Media, 15 (1), 14–29.
– Lebowitz, M. A. (1986), Too Many Blindspots on the Media, Studies in Political
Economy, 21 (1), 165–73.
– Marx, K. (1991), Capital: A Critique of Political Economy, Volume III, London:
Penguin Classics.
– Mazzucato, M. (2019), The Value of Everything: Making and Taking in the Global
Economy, Penguin.
– Meeker, M. (2018), Internet Trends Report 2018, TechCrunch. Accessed 13 November
2019 at https://www.slideshare.net/joshsc/techcrunch-mary-meeker-2018-internet
-trends-report
– Microsoft (2019), Annual Report 2019. Accessed 12 November 2019 at https://www
.microsoft.com/investor/reports/ar19/index.html
– Neocosmos, M. (1986), Marx’s Third Class: Capitalist Landed Property and Capitalist
Development, The Journal of Peasant Studies, 13 (3), 5–44.
– Perelman, M. (2003), Intellectual Property Rights and the Commodity Form: New
Dimensions in the Legislated Transfer of Surplus Value, Review of Radical
Political Economics, 35 (3), 304–11.
– Posner, E. A. and E. G. Weyl (2018), Want Our Personal Data? Pay for It, The Wall
Street Journal, 20 April. Accessed 25 April 2018 at https://www.wsj.com/articles/
want-our-personal-data-pay-for-it-1524237577 – Christophers, B. (2019), ‘The Rentierization of the United Kingdom Economy’,Environment and Planning A: Economy and Space. https://doi.org/10.1177/
0308518X19873007
– Rigi, J. and R. Prey (2015), Value, Rent, and the Political Economy of Social Media,
The Information Society, 31 (5), 392–406.
– Robinson, B. (2015), With a Different Marx: Value and the Contradictions of Web 2.0
Capitalism, The Information Society, 31 (1), 44–51.
– Sadowski, J. (2019), Landlord 2.0: Tech’s New Rentier Capitalism. Accessed
11 October 2019 at https://onezero.medium.com/landlord-2–0-techs-new-rentier
-capitalism-a0bfe491b463
– Sadowski, J. (2020), The Internet of Landlords: Digital Platforms and New Mechanisms
of Rentier Capitalism, Antipode, 52 (2), 562–80.
– Sanyal, K. (2013), Rethinking Capitalist Development: Primitive Accumulation,
Governmentality and Post-Colonial Capitalism, New Delhi: Routledge India.
– Smythe, D. (1977), Communications: Blindspot of Western Marxism, Canadian
Journal of Political and Social Theory, 1 (3), 1–27.
– Srnicek, N. (2016), Platform Capitalism, Cambridge: Polity Press.
– Stalder, F. (2018), Intellectual Property, Krisis, 2, 83–5.
– Taylor, P. and R. Waters (2011), Google Snaps up Motorola Mobility, Financial
Times, 15 August. Accessed 12 November 2019 at https://www.ft.com/content/
e906bedc-c734–11e0-a9ef-00144feabdc0
– Terranova, T. (2000), Free Labor: Producing Culture for the Digital Economy, Social
Text, 18 (263), 33–58.
– The Economist (2018), Should Internet Firms Pay for the Data Users Currently Give
Away?, 11 January. Accessed 25 April 2018 at https://www.economist.com/news/
finance-and-economics/21734390-and-new-paper-proposes-should-data-providers
-unionise-should-internet
– Toupin, L. (2018), Wages for Housework: A History of an International Feminist
Movement, 1972–77, London: Pluto Press.
– Wark, M. (2019), Capital Is Dead, London: Verso.
– Weise, K. (2019), Amazon Knows What You Buy. And It’s Building a Big Ad
Business From It, The New York Times, 20 January. Accessed 12 November 2019
at https://www.nytimes.com/2019/01/20/technology/amazon-ads-advertising.html,
https://www.nytimes.com/subscription
– Zeller, C. (2007), From the Gene to the Globe: Extracting Rents Based on Intellectual
Property Monopolies, Review of International Political Economy, 15 (1), 86–115.
– Zuboff, S. (2019), The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future
at the New Frontier of Power, London: Profile Books.
Note
- I miei ringraziamenti a Matt Cole, Julieta Haidar, Maarten Keune, Michal Rozworski e Jathan Sadowski per i loro commenti su una versione precedente di questo articolo. ↩︎
- Questo articolo renderà espliciti alcuni degli argomenti che erano solo impliciti – o incompleti – nel mio precedente libro Capitalismo delle Piattaforme (Srnicek 2016). ↩︎
- Christian Fuchs, ad esempio, calcola che Facebook abbia ricevuto 64 miliardi di ore di lavoro non retribuito nel 2011 (Fuchs 2014, p. 105). Secondo qualsiasi standard ragionevole, questo suggerirebbe una vasta espansione del plusvalore e un significativo aumento del tasso di profitto. Un critico delle mie tesi potrebbe tuttavia affermare che in assenza di questa nuova fonte di plusvalore il capitalismo si troverebbe in una situazione ancora più grave di quella attuale. Questo potrebbe effettivamente essere vero, sebbene il critico dovrebbe poi dimostrare i tempi e i modi in cui questa nuova fonte si è gradualmente espansa e ha impattato sul pool globale di plusvalore. ↩︎
- Vale la pena notare, però, che il più noto sostenitore della tesi del lavoro gratuito, Christian Fuchs, respinge l’idea dei salari per il lavoro su Facebook, preferendo invece il reddito di base universale come una risposta migliore. ↩︎
- L’interazione rilevante dipende dal modello di prezzo utilizzato per la pubblicità: costo per clic o costo per impression. ↩︎
- Sebbene un’esegesi testuale dettagliata dell’origine dell’errore di Fuchs vada oltre lo scopo di questo articolo, riteniamo che derivi dalla confusione tra l’idea morale e la concezione economica di sfruttamento. Ad esempio, quando risponde ai critici e cerca di giustificare una visione ampia della produzione di valore, Fuchs tipicamente si basa sull’intuizione che una particolare attività è (moralmente) sfruttata e poi afferma che, poiché l’attività è (economicamente) sfruttata, essa è quindi produttrice di valore. ↩︎
- Con il suo focus sulla pubblicità e i dati personali, le critiche che seguono si applicano anche alla nozione di “capitalismo della sorveglianza” (Zuboff 2019). ↩︎
- Ci concentriamo sulle piattaforme occidentali in questo articolo, ma le principali piattaforme cinesi tendono a dipendere ancora meno dai ricavi pubblicitari. Alibaba, con una stima generosa, ottiene solo il 6% dei suoi ricavi dalla pubblicità, Tencent il 18%, e persino Baidu è (in confronto con le piattaforme dell’Occidente) significativamente meno dipendente dalla pubblicità, con il 73% dei suoi ricavi provenienti da quel segmento (fonte: rendiconti finanziari del terzo trimestre 2019). ↩︎
- La discussione seguente si basa sulle ripartizioni dei ricavi trovate nei documenti 10-K e 10-Q di queste aziende. ↩︎
- Notare che questa uguaglianza si basa sull’assunzione di un libero flusso di capitale, senza barriere. Come vedremo più avanti, in assenza di questo libero flusso di capitale, alcune aree possono mantenere tassi di profitto insolitamente elevati. ↩︎
- Il primo processo riveste anche un ruolo importante nei modi in cui genera catene globali di valore gerarchiche attraverso le quali il surplus-valore viene prodotto nei paesi in via di sviluppo e poi trasferito alle principali aziende del mondo sviluppato (Caffentzis 2013; Dedrick et al. 2010). Questo processo, tuttavia, è più rilevante per le imprese produttrici di beni con ampie catene di approvvigionamento, come Apple, piuttosto che per le aziende di piattaforma che si appropriano di rendite come Google e Amazon. ↩︎
- Gran parte della discussione che segue si baserà implicitamente sull’analisi di Marx delle rendite (Marx 1991, pp. 751–950). ↩︎
- Brett Christophers aggiunge una seconda condizione a questa definizione: “condizioni di mercato di concorrenza limitata o assente” (Christophers 2019, p. 2). Questa condizione la deriva dalla comprensione convenzionale della rendita, che considera le condizioni di mercato di un bene. L’argomento di Christophers è che il controllo monopolistico di un bene non è sufficiente a garantire che si accumuli una rendita – ad esempio, la proprietà monopolistica di un bene per il quale sono facilmente reperibili beni sostitutivi significa che i compratori si orienteranno semplicemente verso il bene sostitutivo piuttosto che pagare la rendita. Tuttavia, questa ultima condizione sembra più simile a una caratteristica che (parzialmente) determina la quantità di rendita piuttosto che determinare se esista o meno una rendita. Per questo motivo, ci atteniamo alla definizione più tradizionale marxista e eterodossa di rendita. ↩︎
- In Platform Capitalism ho distinto tra piattaforme cloud e industriali, sebbene ora non creda più che questa distinzione indichi qualcosa di più di una differenza superficiale. Al massimo, esiste una distinzione tra il generale e il particolare. ↩︎
- Con riferimento alla terminologia di Marx, i canoni di proprietà intellettuale (IP) sono una forma di rendita monopolistica piuttosto che una rendita differenziale. In termini generali, la rendita monopolistica si accumula per un rentier in virtù del controllo monopolistico su un bene (ad es. terra in generale). Al contrario, la rendita differenziale si accumula inizialmente per un capitalista che ha accesso a un bene del rentier (ad es. terra particolarmente produttiva), il che consente un processo di produzione più economico. I profitti eccedenti generati grazie all’accesso al bene di qualità superiore sono poi appropriati dal rentier. ↩︎
- La quantità esatta di rendita dipende da diversi fattori. Come nota Christian Zeller, «L’ammontare della rendita monopolistica dipende dalle concrete condizioni di domanda e offerta. Maggiore è l’elasticità della domanda rispetto agli aumenti di prezzo, più alta sarà la rendita. Se esistono beni sostitutivi, la domanda è più elastica e quindi la rendita monopolistica è minore. Maggiore è la localizzazione strategica di un brevetto in un percorso di sviluppo tecnologico, o più ampio è il campo coperto dal brevetto, più numerosi e più elevati saranno i ricavi da licenza che il proprietario può ottenere da tutti coloro che desiderano utilizzare il brevetto per lo sviluppo di tecnologie e prodotti. A differenza della rendita differenziale, che nasce a causa di terreni situati in modo diverso o più fertili, non può emergere una rendita differenziale informativa, poiché ogni informazione racchiusa è unica e viene normalmente utilizzata in ogni caso per la produzione di prodotti specifici» (Zeller 2007, p. 98) ↩︎
- Più precisamente, ci sono ancora dei limiti all’accesso e alla replicazione degli asset immateriali, e quindi dobbiamo essere cauti nel non assumere che questi costi siano zero. Fare quest’ultima assunzione spesso porta a conclusioni eccessivamente ottimistiche e a credenze errate in una «rottura» con il capitalismo. ↩︎
- Basato sui calcoli effettuati a partire dai bilanci 10-Q per il terzo trimestre del 2019. ↩︎
- Come sostiene Brett Caraway, “le attività dei produttori di contenuti non retribuiti permettono alle imprese di ridurre i costi (c+v) delle nuove merci mediali (contenuti e ricerca di mercato), aumentando così il tasso di profitto (s / c+v) e il tasso di surplus value (s / v). Nella misura in cui il lavoro gratuito contribuisce a questo processo, dovrebbe informare la nostra analisi del valore” (Caraway 2016, p. 77). ↩︎
- Calcolo basato sul bilancio finanziario di Amazon per l’anno fiscale 2017 (10-K). ↩︎
- È importante sottolineare che con i termini produttivo e improduttivo non intendiamo fornire alcun giudizio morale, né suggeriamo che l’improduttivo sia privo di utilità per la società. Intendiamo semplicemente ciò che è produttivo di valore per il capitalismo, una categoria che troppo spesso esclude attività che noi considereremmo utili per la società. ↩︎
- Vedere https://fred.stlouisfed.org/series/PNFI ↩︎